![]()
(da Griseldaonline)
-
manuale su linguaggio XML e DTD Tei
Elenco dei codici
(immagini digitali)
![]() f.
191r, UCB 102, The Bancroft Library, University of California, Berkeley
f.
191r, UCB 102, The Bancroft Library, University of California, Berkeley
![]() f.
17r, UCB 085, The Bancroft Library, University of California, Berkeley
f.
17r, UCB 085, The Bancroft Library, University of California, Berkeley
![]() f.
7r, Riccardiano 1035 (O.II.17), Biblioteca Riccardiana, Firenze
f.
7r, Riccardiano 1035 (O.II.17), Biblioteca Riccardiana, Firenze
![]() f.
44, Plimpton MS 119, Rare Book And Manuscript Library, Columbia
University, New York
f.
44, Plimpton MS 119, Rare Book And Manuscript Library, Columbia
University, New York
![]() f.
183, De Bellis La. 01, J. Paul Leonard Library, San Francisco State
University, San Francisco
f.
183, De Bellis La. 01, J. Paul Leonard Library, San Francisco State
University, San Francisco
![]() f.
99, Lodge MS 02, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University,
New York
f.
99, Lodge MS 02, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University,
New York
![]() c.
701r, filza XXVIII, Fondo Mediceo avanti Principato, Archivio di
Stato di Firenze
c.
701r, filza XXVIII, Fondo Mediceo avanti Principato, Archivio di
Stato di Firenze
![]() c.
413r, filza XII, Fondo Mediceo avanti Principato, Archivio di Stato
di Firenze
c.
413r, filza XII, Fondo Mediceo avanti Principato, Archivio di Stato
di Firenze
XML/TEI per la trascrizione delle fonti primarie e la codifica dell'apparato
Francesca Tomasi
La fase di trascrizione delle fonti primarie è una forma
di intervento interpretativo sulle istanze strutturali, semantiche
e materiali trasmesse da una fonte testuale in quanto significa individuare
quali sono gli elementi pertinenti ai fini di un'adeguata rappresentazione
della fonte in oggetto.
In questo senso XML offre ampie possibilità, consentendo allo studioso
di elaborare documenti well-formed in cui la codifica è
espressione soggettiva, in-text, delle volontà dell'interprete
o di sviluppare DTD (Document Type Definition) ad hoc per
la tipologia testuale (testo in prosa, in versi, testo drammatico, ecc.)
o per le esigenze ermeneutiche (scopi della resa elettronica).
Elaborare DTD è operazione complessa che richiede competenze di
alto livello nell'ambito dei linguaggi di markup; la scelta della
TEI (Text Encoding Initiative) orienta invece la codifica verso
uno schema divenuto ormai oggetto di studi decennali e la completezza
dei marcatori previsti assicura una codifica in grado di prevedere ogni
fenomeno testuale (cfr. TEI P4, rilasciata nel 2002; sito ufficiale http://www.tei-c.org/).
La stessa proliferazione di sistemi di implementazione di oggetti digitali
dimostra l'esigenza di un sistema standard di codifica delle fonti primarie.
Per agevolare l'impiego della DTD i progettisti della TEI (Association
for Computers and the Humanities (ACH) la Association for Computational
Linguistics (ACL) e la Association for Literary and Linguistic
Computing (ALLC)) hanno previsto una divisione dello schema di codifica
in tre grandi blocchi, ognuno strutturato in frammenti: core tag set,
elementi presenti in tutti i documenti TEI e quelli del TeiHeader;
base tag set, suddiviso in prosa, versi, testo drammatico, testi
parlati, dizionari, ecc.; additional tag set sono compresi, fra
gli altri (links, analisi stilistica, gestione di corpora linguistici,
nomi e date, ecc.), due frammenti:
a) TRASCRIZIONE DELLE FONTI PRIMARIE: TEI.transcr
(teitran2.dtd e teitran2.ent)
b) CODIFICA DELL'APPARATO CRITICO: TEI.textcrit (teitc2.dtd
e teitc2.ent)
È evidente che in fase editoriale questi marcatori andrebbero accompagnati da quelli base per la descrizione della struttura del documento, per la codifica degli elementi ritenuti rilevanti (per esempio nomi di persona o riferimenti di luogo), per la gestione dei link interni al documento, per la dichiarazione della presenza di intestazioni e piè di pagina, ecc. Ma soprattutto rispetto al trasferimento in MRF di qualsivoglia fonte testuale la trascrizione di fonti primarie (siano esse manoscritti, incunaboli o cinquecentine) non può esimersi dal registrare le informazioni trasmesse dalla componente "materiale" del testo. Il testo in questo senso non è solo una sequenza di stringhe di caratteri, altri elementi devono essere annotati: l'uso dei colori come strumento di enfasi, di struttura o decorativo; la resa in layout dei segni dello scriba nella pagina; i passaggi di mano e di scrittura; le indicazioni di correzioni, annotazioni, cancellazioni, le caratteristiche fisiche del manoscritto esso stesso.
Vediamo dunque nel dettaglio quali sono i marcatori che consentono di codificare gli aspetti specifici della trascrizione.
a) TRASCRIZIONE DELLE FONTI PRIMARIE (manoscritti, incunaboli e antichi testi a stampa)Si possono individuare varie sezioni di interesse. Le più interessanti riguardano:
1. la codifica delle alterazioni del testo (abbreviazioni, cancellazioni, riscritture);
2. la codifica di fenomeni "non linguistici" (identificazione di mani diverse, punti illeggibili, danneggiati o deteriorati, inusuali spaziature nel testo)
1. Core set per la trascrizione
del testo, cioè per la codifica delle "alterazioni"
del testo come cancellazioni, sovrascritture e riscritture, espunzioni,
aggiunte marginali, scioglimento di abbreviazioni, ecc. (Altered, Corrected,
and Erroneous Texts, secondo la definizione delle TEI Guidelines ).
Nello specifico vediamo alcuni marcatori:
Abbreviazioni e scioglimento di abbreviazioni
<abbr>
codifica un'abbreviazione di qualsiasi tipo.
<expan>
codifica lo scioglimento di un'abbreviazione.
Possono essere usati uno come attributo dell'altro, a seconda si intenda
trascrivere il testo abbreviato o lo scioglimento del testo. L'attributo
type può essere poi usato per specificare
il tipo di abbreviazione (nota tironiana, troncamento, contrazione, ecc.).
Le abbreviazioni andrebbero indicate sottoforma di riferimento di entità,
le cui modalità di scioglimento o visualizzazione viene specificato
nella dichiarazione di entità della DTD (p con l'asta inferiore
tagliata sta per "per", la linea soprascritta sta per la lettera
"n", ecc.).
Es.
<abbr expan="non">&n-trattosovrascritto;</abbr>
<expan abbr ="&p-astainferiore;">per</abbr>
Questo stesso sistema di impiego dei riferimenti di entità può essere utile anche per codificare alcuni caratteri che identificano il sistema scrittorio di un autore, vale a dire alcuni segni di scrittura particolari (cfr. Zibaldone Laurenziano). Questo significa che un riferimento di entità può essere associato ad un'immagine e quindi sostituito, in fase di layout, con l'immagine della lettera. Per esempio possiamo dire che &pro; venga sostituito, in fase di visualizzazione con la corrispettiva immagine digitale
 Immagine
delle più comuni abbreviazioni dei manoscritti latini medievali.
Immagine
delle più comuni abbreviazioni dei manoscritti latini medievali.
Tratto da G. Cencetti, Paleografia latina, II ed. Jouvence, Roma
1997, p. 163. Cfr. Anche A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine
ed italiane, ristampa, Hoepli, Milano 1998.
Correzioni e congetture
<sic> codifica
una porzione di testo che viene riprodotta anche se in apparenza scorretta.
<corr>
codifica la forma corretta di un passaggio apparentemente errato.
Anche in questo caso possono essere usati uno come attributo dell'altro,
a seconda della versione del testo si intenda riprodurre. In realtà
più che di congetture, come vorrebbe la TEI, si può parlare
di semplice errore del copista che viene corretto in fase di trascrizione.
<sic corr="uomo">umo</sic>
<corr sic="umo">uomo</corr>
Aggiunte e cancellazioni
<add> codifica
lettere, parole o frasi inserite nel testo dall'autore, dal copista, da
un correttore, da un glossatore o annotatore. L'attributo place
può essere utilizzato per specificare la posizione dell'aggiunta
(inline, supralinear, infralinear, left, right, top, bottom)
<del> codifica
lettere, parole o frasi cancellate nel testo, o segnate come da cancellare,
o comunque indicate come superflue dall'autore, dal copista, da un correttore,
da un glossatore o annotatore. L'attributo rend
può essere utilizzato per indicare il tipo di cancellazione (erasure,
bracketed, overstrike, subpunction)
Esempio di aggiunta marginale e di cancellazione (testo espunto e depennato)
Sostituzioni
Spesso cancellazioni o errori vengono rimpiazzati dal copista o da altra
mano con altre stringhe di testo; questo fenomeno può essere codificato
con:
<sic>
e <corr>,
da utilizzare l'uno gerarchicamente dipendente dall'altro per codificare
una sequenza di sostituzioni;
<del> e
<add>, usati
in sequenza per evidenziare che una porzione di testo è stata prima
cancellata e poi è stato aggiunto altro testo.
Esempio di cancellazione
e aggiunta
Ripristino di porzioni in precedenza cancellate e altri
segni di evidenziazione
Un autore può decidere di evidenziare una parola o una frase in
qualche modo e poi riflettere di cancellare l'evidenziazione. Ad esempio
una porzione di testo può essere evidenziata come da cancellare
e poi la cancellazione essere eliminata, e quindi provvedere al ripristino
del testo prima cancellato.
L'elemento <restore>
indica il ripristino di un testo ad uno stadio precedente la cancellazione
o altro segno di evidenziazione o istruzione di modifica.
Testo omesso nella trascrizione
<gap> indica
un punto del testo una porzione non è stata inserita nella trascrizione
elettronica (per esempio in quanto illeggibile oppure perché mancante).
L'attributo desc
può essere utilizzato per spiegare la ragione dell'omissione, mentre
l'attributo extent
consente di specificare la dimensione della omissione (esprimibile in
numero di lettere o in centimetri)
<supplied>
indica la presenza di una stringa di testo come possibile integrazione
della lacuna.
Altri elementi rilevanti
<hi>
evidenzia una parola o una porzione graficamente distinta dal testo circostante
(per esempio un'iniziale rubricata). L'attributo per specificare le caratteristiche
dell'evidenziazione è rend.
Esiste poi l'attributo resp, o l'attributo hand, che consente di assegnare la paternità a certe operazioni, vale a dire di definire chi è il responsabile di certe azioni sul testo, delle interpretazioni o del markup: la mano per un'aggiunta o una cancellazione, lo scioglimento di un'abbreviazione, la correzione di un errore apparente, la regolarizzazione di una forma non standard (normalizzazione della voce), la trascrizione di porzioni non chiare, la decisione di non trascrivere alcune porzioni di testo.
2. Sezione dedicata ai marcatori per la codifica di fenomeni non linguistici
nella fonte d'origine: il punto in cui cambia la mano dello scriba, con
quali caratteristiche varia la scrittura (diverso inchiostro o diverso
strumento di scrittura), punti in cui il testo è danneggiato o
illeggibile, spazi inusuali o linee nella fonte.
Alcuni
esempi di scritture. L'evoluzione dei sistemi scrittorei.
Tratto da A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, nuova
ed. Bagatto, Roma 1992, p. 206.
Identificazione e descrizione delle mani diverse nei
documenti
Elemento <hand>
Usato nell'intestazione <teiHeader> (nella sezione del <profileDesc>)
per distinguere ogni scriba e ogni diverso stile di scrittura. Le indicazioni
delle varie mani (cioè ogni elemento <hand>) vanno inserite
all'interno del marcatore <handList> (cioè lista delle varie
mani)
Vediamo alcuni degli attributi utilizzabili per identificare le varie
mani :
id come identificativo
univoco usato poi nel documento per riferirsi ad uno scriba o ad uno stile
di scrittura;
type per identificare il tipo di
scrittura
scribe per assegnare il nome o l'identificativo di ogni scriba;
style per indicare lo stile di scrittura;
ink per descrivere il colore dell'inchiostro;
character per descrivere altre caratteristiche della mano;
resp per indicare il nome dell'editore o del trascrittore responsabile
per l'identificazione della mano.
Ogni punto del testo in cui la mano cambia viene codificato
con l'elemento vuoto <handShift> accompagnato dagli attributi old
e new per indicare il codice identificativo della precedente mano e il
codice della successiva (codici che corrispondono agli id che accompagnano
le varie hand specificate nell'handList).
Es. <handShift new='2' old='1'/>
Danni, porzioni illeggibili, testi aggiunti
Abbiamo già visto gli elementi <gap> e <supplied>.
Questi marcatori vengono fondamentalmente utilizzati quando il testo è
quasi completamente illeggibile e quindi la porzione mancante è
una congettura. Nell'eventualità in cui invece si possa effettuare
una ragionevole integrazione della lacuna gli elementi da utilizzare sono:
<damage> fa riferimento ad un area di testo danneggiata. Fra gli
attributi type, che permette di specificare la tipologia di danno (abrasione,
macchia, ecc…), agent che consente di specificare, quando possibile,
l'agente che ha causato il danno (attacco microbico, foxing) e extent
che permette di specificare l'estensione del danno (espresso in numero
di lettere, centimetri o porzioni strutturali).
Es.
<damage type='macchia' agent='foxing' extent='3 lettere'/>
<unclear> codifica una parola, una frase o un passaggio che non
viene trascritto in quanto illegibile.
Questi elementi possono anche essere utilizzati uno all'interno dell'altro:
no<damage type='macchia' agent='foxing' extent='3 lettere'> <unclear>str</unclear>um</damage>
Spazi
Lo scriba o il copista può aver lasciato uno spazio bianco nel
testo (per un'iniziale miniata o in quanto non riusciva a leggere dalla
fonte o per qualche altra ragione). L'elemento <space> consente
di rilevare la presenza di una porzione bianca e l'attributo extent di
definirne le dimensioni (in numero di lettere o centimetri). L'elemento
<supplied> può essere utilizzato per integrare la mancanza.
Sarà poi giudizio del codificatore decidere come utilizzare XSLT (Extensible Stylesheet Language - Transformation, linguaggio di visualizzazione di XML sul browser) per rendere in layout i vari fenomeni codificati, ricorrendo a strategie di visualizzazione e resa grafica.
Vediamo un esempio, tratto dalle Novelle Porrettane di Giovanni Sabadino degli Arienti (cod. Palatino 503, c. 64) di applicazione del linguaggio XML (TEI) per la codifica dei segni del manoscritto.
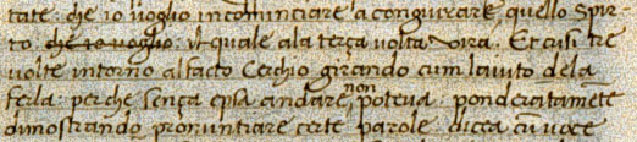 |
|
| TRASCRIZIONE
DIPLOMATICA |
TRASCRIZIONE
CODIFICATA |
| […]/tate: che io uoglio incominciare a congiurare quello Spir/to: [che io uoglio]: il quale ala terça uolta uirá. Et cusi tre/uolte intorno alfacto Cerchio girando cum laiuto dela/ferla: perche sença epsa andare \non/ poteua: ponderatame(n)te/dimostrando pronuntiare certe parole: dicea cu(m) uoce […] | <p> […] <lb
n="205">tate: che io uoglio incominciare a congiurare
quello Spir<lb n="206">to: <del hand="Arienti">che
io uoglio</del>: il quale ala terça uolta uirá.
</p> <p>Et cusi tre<lb n="207"> uolte intorno alfacto Cerchio girando cum laiuto dela<lb n="208"> ferla: perche sença epsa andare <add hand="Arienti" place="interlinea">non</add> poteua: <abbr expan="ponderatamente">ponderatam&e-trattosopra;te</abbr> <lb n=209>dimostrando pronuntiare certe parole: dicea <abbr expan="cum">&cu-trattosopra;</abbr> uoce […]</p> |
Si noti che nella trascrizione diplomatica il valore dei segni utilizzati per interpretare fenomeni di scrittura (aggiunte interlineari, cancellazioni, scioglimento di abbreviazioni) devono essere conosciuti da chi legge e quindi complicano la leggibilità. Con la codifica, gli interventi dell'editore possono essere esplicitamente interpretati.
b) L'apparato critico
L'apparato è il luogo destinato a documentare le scelte compiute
in fase di definizione del testo critico. L'apparato riporta cioè
le varianti riprodotte nei testimoni della tradizione testuale.Tutti gli
elementi visti per la trascrizione delle fonti primarie possono essere
utilizzati anche nell'apparato per codificare le varianti dei codici attestanti
la tradizione testuale.
Le informazioni relative possono essere inserite all’interno del testo codificato e poi visualizzate secondo strategie variabili in sede di layout
L'elemento <app> contiene le varie lezioni ricondotte
dai testimoni della tradizione.
L'elemento <lemm> riporta la lezione accettata nel testo critico,
<rdg> (reading) ogni singola lezione variante. Questo elemento supporta
l'attributo wit (witness) che, come valore, riporta la sigla identificativa
del testimone che tramanda la lezione variante ed eventualmente l'attributo
type che consente di specificare la tipologia della variante (errore di
trascrizione, correzione o intervento sostitutivo).
Es. Tratto da Poggio Bracciolini, Lettere, vol. I Lettere a Niccolò Niccoli, a cura di H. Harth, Olscki, Firenze 1983, p. 109, riga 4.
<app>
<lemm wit='R'>avocarem</lemm>
<rdg wit='M'>avocam</rdg>
<rdg wit='F'>evocarem</rdg>
</app>
La serie delle informazioni sui vari testimoni della tradizione può essere racchiusa all'interno dell'elemento <witList>, che contiene la lista dei testimoni, ciascuno codificato con l'elemento <witness>. L'attributo sigil permette di assegnare una sigla identificativa per ogni testimone (con la quale viene poi richiamato nel testo).
Es.
<witList>
<witness sigil="R">Firenze, Biblioteca Riccardiana, 759</witness>
<witness sigil="M">Venezia, Biblioteca Marciana, Lat.
XI, 66</witness>
<witness sigil="F">Ferrara, Biblioteca Comunale, Cl. II,
133</witness>
...
</witList>